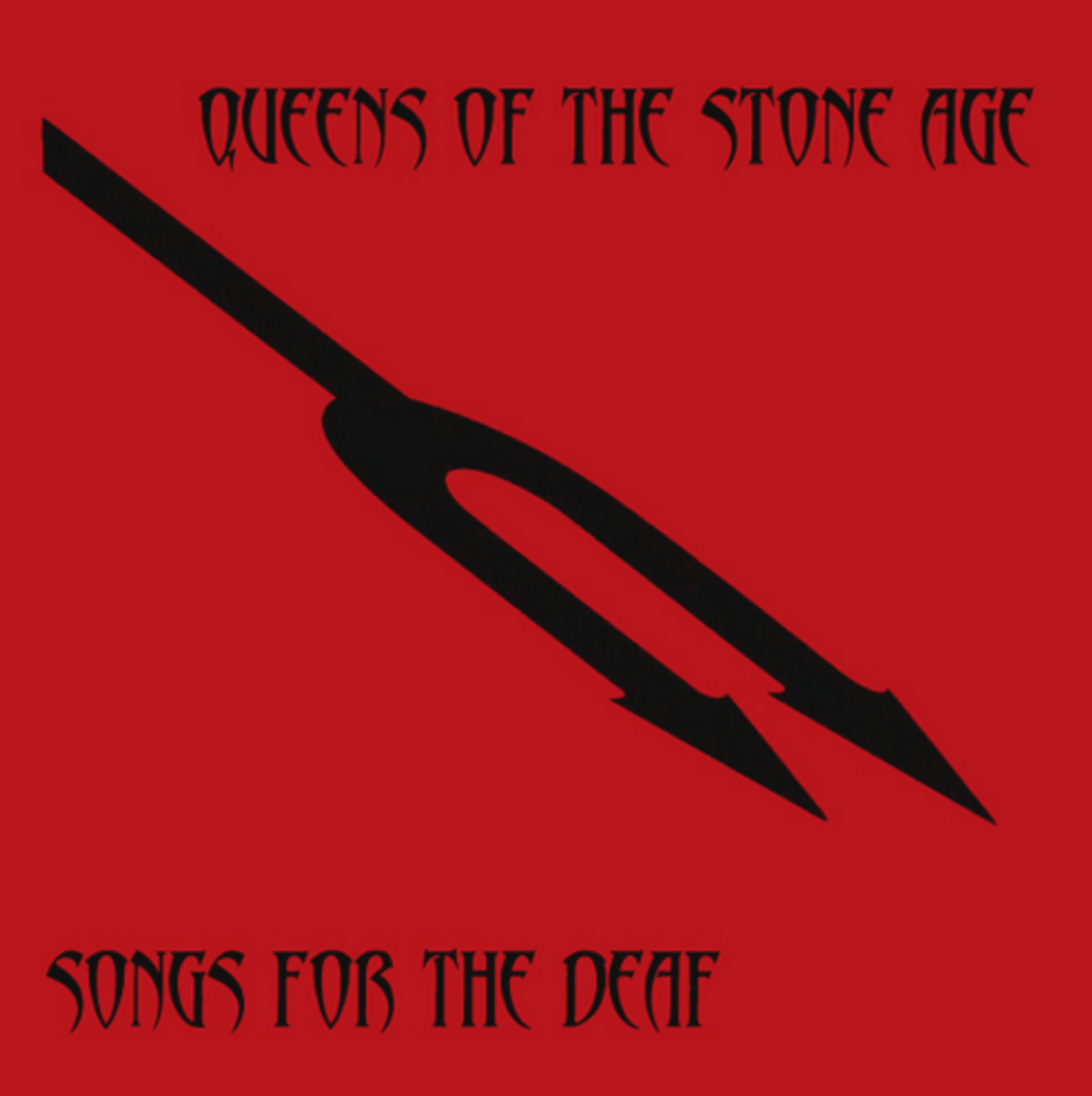di Alessandra Virginia Rossi
Una delle cose più fastidiose che mi sento dire quando rispondo alla spinosa domanda “Che musica ascolti?” è l’altrettanto odioso “Ah…beh non ti ci facevo!”. E allora puntualmente medito su quale aspetto si debba mai avere. Una corporatura particolare? Un vestiario coerente? Bullshit, naturalmente. Però riascoltando “Songs For the Deaf” dei Queens Of The Stone Age mi sono resa conto che è un album che richiede un discreto fisico. Se le rullate di Dave Grohl gli costano tutto quel sudore è inevitabile, o quantomeno doveroso, che anche tu, piccolo comune mortale, che sei all’ascolto di un lavoro così imponente, spenda qualche energia. Sostenere i testi ruvidi di Josh Homme e Mario Lalli non è impresa facile. Le intenzioni sono tutt’altro che buone: “That’s a study of dying, how to do it right”. Il viaggio nel deserto dell’introspezione è condito dagli effetti delle droghe di cui si parla ripetutamente. Homme e soci vogliono spingersi e, soprattutto, spingerci oltre il limite. Oltre i confini dell’umana natura corporea e fallibile. Sfidano addirittura la sordità inserendo un pregap (una traccia molto ghost dal titolo The Real Song for the Deaf da cercare all’inizio del disco) le cui basse frequenze sarebbero udibili anche dagli audiolesi.
Il risultato è decisamente potente perché il tutto suona un po’ come se ti svegliassi di colpo da un torpore chimico e ti accorgessi di essere su una Chevrolet cabrio (preferibilmente rossa) lanciata a velocità su una delle più polverose e assolate highway della bassa California. Proprio lì nasce lo stoner rock in fondo, fra i cactus e l’aridità di una terra che regala intense allucinazioni già dai tempi della grande conquista del West e perfino prima quando gli effetti del peyote erano il cuore del culto nativo americano. Insomma, che abbiate voglia di raggiungere Las Vegas con la stessa disposizione di spirito di Hunter S. Thompson o di schiantarvi contro questo disco a più di 100 miglia orarie (rigorosamente senza freni) in compagnia, fra gli altri, di un Nick Oliveri particolarmente ispirato (per i palati più esigenti si consiglia la versione live di You think I ain’t worth a dollar che lo vede ai vocals) e di un Mark Lanegan da brividi in Song for the Dead, fatelo a vostro rischio e pericolo. E se finisce nel peggiore dei modi Mosquito Song sarà la miglior marcia funebre che potevate desiderare.